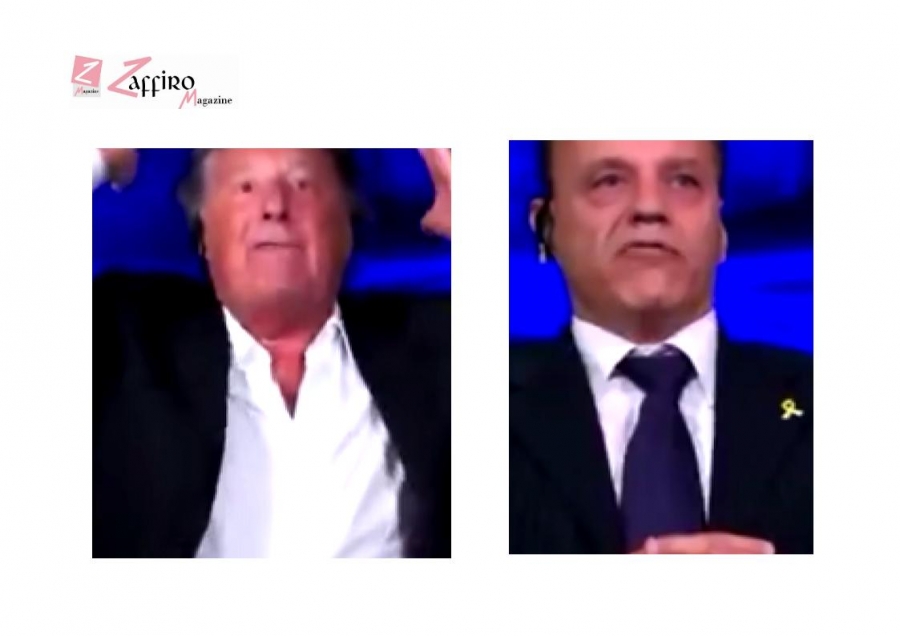Iacchetti rissa in tv: basta questa espressione a evocare la drammaticità della scena che si è svolta martedì 16 settembre nella trasmissione È sempre Cartabianca su Rete 4, condotta da Bianca Berlinguer. Protagonisti dello scontro verbale furioso sono stati Enzo Iacchetti, ben noto al pubblico per il suo lato comico, ma anche per il suo impegno civico, ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Sullo sfondo, la guerra di Gaza, la morte di migliaia di persone, bambini inclusi, e il difficile confine tra opinione, responsabilità politica, offesa e verità storica.
Il racconto della lite
La discussione nasce con toni accesi: Mizrahi afferma che si tratta di una tragedia, ma non voluta da Israele, che Hamas è responsabile sia per l’attacco del 7 ottobre sia per il mancato rilascio degli ostaggi. Iacchetti lo incalza: muoiono molti bambini, non si può giustificare tutto parlando di guerra.
A un certo punto, Mizrahi chiede “Definisca bambino”, frase che pare mettere in discussione le cifre che Iacchetti cita, e che scatena la reazione veemente di questi, tanto che l’attore minaccia di abbandonare lo studio, dicendo: «Dovevi dirmi che c’era una persona priva di ragionamento, non voglio ascoltare queste stron*te».
La tensione sale ancora quando Mizrahi accusa Iacchetti di essere un fascista, parola questa che fa degenerare il confronto: Iacchetti risponde con velocità, tra urla, “Sei un fascista”, “Cosa hai detto stronzo?”, fino alla minaccia esplicita: «Ti prendo a pugni».
Bianca Berlinguer tenta più volte di riportare la calma, ma senza successo immediato; il dibattito sfocia fuori dal controllo, trascendendo la mera discussione politica in qualcosa di personale, urticante, quasi fisico.
Il giorno dopo, le reazioni: Mizrahi dichiara che non è nemico, ma che per fare la pace ci vogliono due, e che la minaccia di Iacchetti (“menarmi”) non favorisce certo un clima di dialogo. Iacchetti, da parte sua, conferma il proprio punto di vista via social: non arretra di un millimetro, rifarebbe ogni sua parola “dalla prima all’ultima”.
Commento: cosa c’è dietro la rissa verbale
Il tema della guerra e delle responsabilità
Non è la prima volta che dibattiti su conflitti armati — specialmente quelli in Medio Oriente — si trasformano in scontri aspri. Quando sono in ballo numeri enormi di vittime civili, morti di bambini, la polarizzazione è quasi inevitabile. Le parti spesso partono da posizioni inconciliabili: per Mizrahi, Israele è uno Stato che combatte un terrorismo reale; per Iacchetti, la narrazione dominante è quella della sofferenza palestinese, della responsabilità israeliana, della verità che deve essere vista. In mezzo, la difficoltà di comunicare dati, fatti, fonti credibili, riferimenti storici. Quando Mizrahi chiede “definisca bambino”, non è solo una domanda tecnica: è un modo per chiamare in causa l’interpretazione, la credibilità, il peso delle parole.
Il valore e il limite del contraddittorio
Il dibattito TV assume la forma di contraddittorio — almeno formalmente — ma nel corso della puntata Iacchetti afferma che “non ci può essere contraddittorio” su certi temi, che “c’è solo un esercito”. Questo svela qualcosa di più profondo: non è solo una questione di opinioni diverse, ma di cosa si ritiene credibile, giustificabile o moralmente ammissibile. Il limite del contraddittorio emerge quando una parte sente che l’altro nega, minimizza, o riformula la verità storica delle sofferenze.
L’escalation verbale: insulti, minacce, emozione
Le parole “fascista”, “stronzo”, “ti prendo a pugni” non sono retorica lieve: sono parole che segnano un confine tra dialogo e aggressione. Mostrano che per Iacchetti non si tratta solo di difendere una posizione, ma di reagire contro qualcosa che percepisce come ingiustizia, come menzogna, come violazione morale. Però queste stesse parole corrono il rischio — e lo producono — di svuotare il confronto, rendendolo spettacolo, emozione, scontro identitario più che scambio di idee.
Il ruolo della televisione, del format, del pubblico
In televisione, in un talk show, c'è una doppia pressione: quella del tempo, della scaletta, dell’audience, e quella del momento politico. Gaza è un tema che infiamma opinioni, di tutti i tipi. Il conduttore ha il compito di mediare ma anche di stimolare; il pubblico vuole chiarezza, ma spesso vuole anche spettacolo — o è spinto a seguirlo, comunque. Qual è la linea tra informare e intrattenere? Quando il conflitto diventa tema caldo, la televisione rischia di accentuare la polarizzazione piuttosto che aiutare a comprendere.
Qualche riflessione finale
Il gesto di Iacchetti, forte, rabbioso, mostra che c’è un orrore difficile da tenere dentro. Davanti a notizie di sofferenza, di bambini morti, di tragedie umanitarie, molti sentono che non basta il discorso composto, che occorre urlare la propria indignazione. Ma urlare rischia di soffocare anche la dialettica, l’ascolto, la possibilità che l’altro possa cambiare idea, o quantomeno capire meglio.
D’altra parte, Mizrahi non è un semplice interlocutore: rappresenta un punto di vista che viene vissuto da Iacchetti come “parte opposta”, e che spesso è accusato — da chi la pensa come Iacchetti — di usare numeri “ufficiali” non sempre verificabili, di fornire versioni che minimizzano o giustificano atti controversi. Anche per questo lo scontro verbale: quando la verità è sentita come sotto attacco, la reazione è istintiva, a volte non misurata.
In fondo, quello che è successo è anche un segnale del malessere pubblico: quando il dolore è enorme, quando le informazioni sono molteplici e spesso contraddittorie, quando le opinioni vengono polarizzate da media, politici, social network, la tv diventa il teatro di una lotta morale oltre che politica.
Conclusione
La rissa televisiva tra Iacchetti e Mizrahi non è solo l’ultimo capitolo di dibattiti infuocati su Gaza: è un riflesso di quanto oggi sia difficile trovare spazi per il dialogo razionale, per il confronto basato su dati e fonti certe, per il rispetto anche di chi la pensa diversamente. È il segno che, quando la posta in gioco è il dolore, la verità, la responsabilità, spesso le parole scadono, gli animi si accendono, e la speranza che il confronto serva a qualcosa rischia di sbriciolarsi sotto il peso delle emozioni.
Forse si può augurare che episodi come questo ci facciano riflettere non solo su chi “ha ragione”, ma su come si dice, come si ascolta, come si resiste alla tentazione della semplificazione. Perché la verità, più che vincere, ha bisogno di essere cercata — insieme.