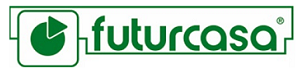Chi ha la fortuna di avere nel proprio orto o nel giardino una pianta di melo cotogno, tra pochi giorni potrà raccogliere i suoi preziosi frutti e trasformarli in dolcissime marmellate o nell’insuperabile cotognata.
Ricordo ancora che, alla mia frequente domanda di cioccolata, mi veniva spesso risposto: “È finita, ma c’è la cotognata”. Si, perché la cotognata era considerata al pari della cioccolata anzi, per molti di noi che giravamo ancora con i calzoni alla zuava, era la preferita. Bella soda, granellosa, dolce ma asprigna, insomma…. buonissima. Mia nonna Marianna la faceva spesso e ricordo ancora la gioia di quando prendeva in mano la scatola di latta da cui prelevava quei fagottini incartati con la carta oleata. Un cartoncino a nipote, una fetta di pane e …. buona merenda!
Tra storia e mitologia
Coltivata già dai Babilonesi, è originaria delle zone del Mar Caspio dove nasce spontaneamente. Il pomo del cotogno veniva considerato frutto caro ad Afrodite e, infatti, a quanto sostiene Plutarco, le donne erano invitate a mangiarlo in occasione della prima notte di nozze per favorire la fertilità. Sia i Romani che i Greci lo consumavano crudo col miele oppure ne facevano un gustoso sidro, utilizzandone la polpa, anche, come antiveleno. Il suo nome Cydonia è quello di una località dell’isola di Creta, da cui si pensa provenga, ma per il colore e la durezza veniva, anche, chiamato Chrysomelon, il famoso pomo d’oro della mitologia.
Il Ricordo…
Non a tutti piace la Cotognata, ma a me evoca un dolce speciale. Ogni volta che penso a quel delizioso dolce, la mia mente si riempie di immagini e profumi avvolgenti. Mia nonna, con le sue mani esperte, la preparava in una versione che rimarrà sempre nel mio cuore. La metteva su un vassoio, tagliata a rombi perfetti e ricoperta da un foglio di carta da forno. Quando la Cotognata era pronta, sulla sua superficie si formavano cristalli di zucchero che scintillavano alla luce, un invito a gustarla.
Io e i miei cugini non riuscivamo a resistere. Correvo su per le scale con il cuore in gola dall’eccitazione, sapendo che quel dolcetto era il nostro preferito. La Cotognata non era solo un dolce, era un momento di gioia e una tradizione che si ripeteva ogni anno. Era un rito che ci univa. È una confettura solida, ottenuta da mele o pere cotogne, frutti antichissimi dal sapore aspro, quasi impossibili da mangiare crudi. Quei frutti, spesso trascurati, diventano preziosi in questa antica ricetta. Con la loro dolcezza particolare si trasformano in un dolce che scalda il cuore, perfetto per i mesi invernali.
La consistenza di questa confettura, simile a una caramella gelée, è un’altra dei suoi tratti distintivi. Il suo inconfondibile colore rosso scuro la rende piacevole al palato e agli occhi. Ogni pezzo è un piccolo tesoro, facile da tagliare e conservare, pronto per essere gustato in ogni momento della giornata. La Cotognata è più di un semplice dolce, è un legame con le radici, un pezzo di storia familiare che vive nei nostri cuori e nei nostri ricordi. È un’esperienza da condividere e tramandare.
La Ricetta di nonna Marianna…
La sua ricetta è molto semplice, forse un po’ lunga, ma ne vale veramente la pena. Sbucciare le mele cotogne, tagliarle a pezzi eliminando la parte centrale e, man mano, immergerle in acqua acidificata con succo di limone. Quando tutte le mele saranno state pulite e tagliate, eliminare l’acqua di immersione e metterle in un tegame alto insieme alle bucce di tre mele, ricche di pectina, un addensante naturale. Coprire a pelo con acqua, lasciare cuocere a fuoco lento mescolando con frequenza e quando saranno cotte, circa 45-60’, passarle con il passatutto a trama fine. Aggiungere lo zucchero al passato e rimettere la purea nello stesso recipiente, proseguendo con la cottura, senza distrarsi perché il rischio che si attacchi sul fondo è elevato. Lasciare cuocere a fuoco basso fino a quando, infilando un cucchiaio nel centro, questo rimarrà dritto. Versare la cotognata in un vassoio o in degli stampini più o meno grandi e lasciare raffreddare. Una volta raggiunta la temperatura ambiente tagliamo la marmellata in pezzetti o la estraiamo dagli stampini, la spolveriamo con lo zucchero semolato e la incartiamo con carta oleata prima di conservarle in una scatola di latta.
Il fascino delle ricette della nonna…
Le ricette della nonna rivestono un ruolo chiave nel tessuto della cucina siciliana. Esse non rappresentano semplicemente una serie di istruzioni per preparare deliziosi piatti, ma sono parte integrante del patrimonio culturale della Sicilia e dell’Italia intera. Queste ricette, tramandate di generazione in generazione, sono l'essenza della tradizione culinaria del nostro Paese, rappresentando un legame tangibile con il passato e un modo per mantenere vive le nostre radici.
Ogni ricetta della nonna racconta una storia, evoca ricordi d'infanzia e sapori familiari. Questi piatti riflettono l'amore, la cura e la saggezza delle nostre nonne, che hanno trasmesso la loro conoscenza culinaria attraverso il cibo. D'altronde, nel nostro Paese, il cibo non è solo nutrimento, ma anche un modo per comunicare, condividere e celebrare.
Preservare queste ricette significa quindi conservare un elemento fondamentale della nostra identità culturale. La cucina della nonna è un patrimonio prezioso che ci aiuta a comprendere meglio chi siamo e da dove veniamo. È un tesoro che dobbiamo valorizzare e continuare a tramandare per non perdere il contatto con le nostre radici e la nostra storia.