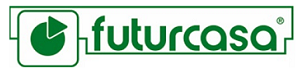Il cammino di Giangiorgio Pasqualotto lungo le vie dell’Oriente non fu mai soltanto un percorso geografico: fu un viaggio intellettuale, spirituale e culturale capace di unire mondi lontani, apparentemente inconciliabili, e di trasformare la percezione della realtà e dell’arte. Nato a Padova nel 1946, Pasqualotto si formò inizialmente nella tradizione estetica occidentale, studiando con passione i testi di Max Bense e dei filosofi della Scuola di Francoforte, come Horkheimer e Adorno. Tuttavia, la sua curiosità innata e il desiderio di superare i confini del pensiero occidentale lo portarono ben presto a rivolgersi verso orizzonti fino ad allora misteriosi e lontani: il Buddhismo, le filosofie orientali, le pratiche contemplative e una concezione dell’arte come esperienza spirituale.
La prima tappa della sua carriera accademica fu la laurea a Padova nel 1969, con una tesi sull’estetica tecnologica di Max Bense. Ben presto, però, la rigidità delle categorie neoidealistiche e la critica severa alla mercificazione culturale da parte dei francofortesi lo spinsero a interrogarsi sul senso più profondo dell’arte. Per Pasqualotto, l’arte non poteva essere semplicemente un oggetto di analisi: essa doveva diventare ponte verso l’esperienza del mondo, occasione di scoperta, riflessione e trasformazione interiore.
Negli anni Settanta, iniziò un’intensa attività di ricerca che lo portò a confrontarsi con il Buddhismo Zen, le filosofie tibetane e le pratiche contemplative. I suoi soggiorni in Giappone, India e Nepal non furono mai semplici periodi di studio, ma autentici scambi culturali nei quali l’Occidente e l’Oriente si arricchivano reciprocamente. A Kyoto, partecipò a una cerimonia del tè in un tempio zen, osservando come la ritualità e la cura dei dettagli trasformassero un gesto semplice in un’esperienza estetica e spirituale profonda. Qui comprese che il senso dell’arte non risiede solo nell’opera, ma nella cura, nell’intenzione e nella presenza che vi si riversa.
In un celebre saggio del 1983, Pasqualotto scrisse: “Non si impara il Buddhismo come si impara un testo: lo si vive, lo si respira, lo si lascia penetrare nella propria quotidianità.” Questo approccio esperienziale segnò una svolta nel suo modo di fare filosofia, spostando l’accento dall’analisi puramente concettuale a una pratica integrale che unisce teoria e vita, pensiero e esperienza.
Un insegnamento che mi ha personalmente trasmesso è stato che si possono integrare pensieri di Eraclito e di Lao Tzu senza falsificarli, trovando un filo comune tra la saggezza occidentale e quella orientale. Mi mostrò che l’insapore è lui stesso un sapore, una lezione che applicava tanto all’arte quanto alla filosofia e alla vita quotidiana, insegnandomi a percepire l’essenza nascosta in ciò che sembra neutro o insignificante.
Il cammino di Pasqualotto fu scandito da numerosi momenti emblematici. Nel 1985, partecipò a un convegno internazionale di studi orientali a Kyoto, dove incontrò maestri zen e studiosi indiani di fama mondiale. Fu lì che comprese come l’estetica occidentale e la meditazione orientale potessero dialogare in maniera feconda, generando una nuova forma di comprensione della realtà, della creatività e del significato della vita. Questo incontro segnò la nascita del suo pensiero più maturo, capace di combinare rigore filosofico e apertura spirituale.
Uno dei temi centrali della sua riflessione fu la nozione di spazio interiore, concepito come luogo di incontro tra il sé e l’alterità. In questo senso, Pasqualotto recuperava alcune intuizioni di Heidegger e di Merleau-Ponty, reinterpretandole alla luce delle esperienze orientali e sottolineando l’importanza del silenzio, della contemplazione e della presenza piena all’esperienza artistica. La sua filosofia, quindi, non si limitava a un approccio teorico: diventava un invito alla trasformazione personale e culturale, capace di incidere sul modo stesso di percepire il mondo.
Negli anni Novanta, Pasqualotto si dedicò con passione all’insegnamento, portando nelle università italiane non solo il sapere occidentale tradizionale, ma anche le discipline orientali. I suoi corsi di Estetica Comparata e Filosofia dell’Arte Contemporanea diventarono rapidamente punti di riferimento per studenti e studiosi desiderosi di approfondire il dialogo tra culture. La sua metodologia era unica: combinava lezioni frontali con esercizi pratici di meditazione, osservazione artistica guidata e momenti di confronto collettivo, stimolando una sensibilità aperta e multidimensionale.
Parallelamente, Pasqualotto fu un prolifico scrittore. I suoi libri e articoli costituiscono un corpus intellettuale ricco e articolato, attraversando discipline, culture e confini geografici. In opere come “Estetica e Contemplazione” e “L’Oriente dentro l’Occidente”, egli mostrava come il contatto con filosofie lontane potesse stimolare nuove letture dei testi occidentali, rivelando connessioni inattese tra forme artistiche, pratiche spirituali e riflessioni etiche. Per Pasqualotto, l’arte era specchio della vita, veicolo di saggezza e strumento di crescita interiore.
Un aneddoto illuminante riguarda il suo soggiorno a Lhasa, capitale del Tibet. Qui, durante una visita a un monastero buddista, rimase profondamente colpito dal modo in cui i monaci integravano pittura sacra, mantra e meditazione quotidiana. Raccontava spesso che quella esperienza gli mostrò come l’arte possa essere pratica spirituale: un mezzo per trasformare la mente e il cuore, non semplicemente un oggetto da contemplare.
Non meno significativa fu la sua attenzione alla dimensione sociale e culturale. Pur immerso nello studio delle filosofie orientali, Pasqualotto non trascurava le sfide del presente occidentale: disuguaglianze, mercificazione culturale, crisi del senso e della bellezza. Il suo approccio multidisciplinare gli permetteva di affrontare questi temi con profondità e leggerezza, proponendo una visione dell’arte come strumento di riflessione critica e rinascita spirituale.
Il cammino di Pasqualotto si tradusse anche in numerose collaborazioni internazionali. Partecipò a seminari in Cina, Corea del Sud e Nepal, instaurando rapporti duraturi con studiosi e artisti locali. Questi contatti gli permisero di approfondire la conoscenza della calligrafia, della pittura sacra e delle pratiche meditative, elementi che integrò con grande sensibilità nei suoi insegnamenti e nelle sue pubblicazioni. Per lui, la vera comprensione non era mai superficiale: richiedeva ascolto attento, dedizione e una costante apertura all’apprendimento reciproco.
Un altro aspetto fondamentale della sua ricerca fu la riflessione sul tempo e sulla memoria. Influenzato dalla filosofia orientale, Pasqualotto riconsiderava la linearità temporale tipica dell’Occidente, proponendo un approccio più circolare e integrato, in cui passato, presente e futuro si influenzano reciprocamente. Questo pensiero si rifletteva anche nella sua concezione dell’opera d’arte, che diventava spazio temporale aperto, capace di dialogare con il fruitore in modo diretto e trasformativo.
Il rapporto con gli studenti e i lettori era altrettanto significativo. Pasqualotto non si limitava a trasmettere conoscenze, ma stimolava curiosità, meraviglia e responsabilità etica. Le sue lezioni erano accompagnate da citazioni di grandi maestri orientali e occidentali, esercizi di scrittura e momenti di riflessione condivisa. Chi lo incontrava per la prima volta rimaneva colpito dalla semplicità con cui riusciva a rendere comprensibili concetti complessi e dalla coerenza della sua vita con il pensiero che professava.
Negli ultimi anni, pur rallentando l’attività pubblica, Pasqualotto continuava a scrivere e a riflettere, convinto che la filosofia dovesse restare aperta, fluida e capace di adattarsi ai cambiamenti culturali e sociali. La sua eredità non si limita ai testi e alle lezioni, ma si estende a un modo di intendere la vita, la conoscenza e l’arte come esperienze integrate e profondamente umane.
La morte di Giangiorgio Pasqualotto, avvenuta il 6 ottobre 2025, ha suscitato commozione nel mondo accademico e culturale. In molti ricordano la sua capacità di coniugare rigore e apertura, tradizione e innovazione, Oriente e Occidente. La sua vita rappresenta un esempio di come il viaggio – intellettuale, spirituale e umano – possa trasformare non solo chi lo compie, ma chi lo osserva, arricchendo prospettive e ampliando orizzonti.
Pasqualotto ci lascia l’invito a continuare il cammino con curiosità, rispetto e passione, ricordandoci che la filosofia non è soltanto esercizio teorico, ma esperienza di vita e apertura verso l’ignoto. Le sue opere, i suoi insegnamenti e la sua esistenza testimoniano che il dialogo tra culture e la ricerca di significato possono creare una sintesi feconda, capace di illuminare anche i percorsi più complessi.
In conclusione, il cammino di Pasqualotto lungo le vie dell’Oriente è emblematico di un modo di fare filosofia che non si ferma ai confini del libro o della cattedra, ma si fa esperienza, vita vissuta e condivisione. La sua visione della cultura come ponte tra mondi diversi resta un punto di riferimento per chiunque creda nella possibilità di un sapere che sia insieme profondo, umano e trasformatore. Il cammino continua nelle menti e nei cuori di chi lo ha incontrato, come un flusso incessante di conoscenza, bellezza e saggezza.